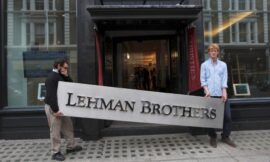Queste occasioni conferiscono un certo timore. Perché questo è il giorno in cui si ricordano, si celebrano, dei fatti grandi. Grandi per Cavriglia, grandi per la Toscana, grandi per la storia di quegli anni, così martoriati e penosi.
E allora la preoccupazione è quella di non essere all’altezza di quei fatti, di quelle vite spezzate. 191 persone. Il 4 luglio del ’44, 191 civili furono rastrellati, mitragliati e bruciati da reparti tedeschi specializzati della Herman Goering a Meleto, Castelnuovo, Massa e San Martino. Vorremmo conoscerli tutti quei nomi. Vorremmo citarli uno ad uno. Vorremmo conoscere la vita successiva dei loro cari, dei loro parenti, dei loro amici.
C’è chi dice che da queste parti, non lontano da qui, per fatti analoghi, ci sia ancora chi si è portato il ricordo fino alla vecchiaia senza poterne mai parlare, come se per sopravvivere fosse in qualche modo stato costretto a rimuovere. C’è chi dice che quando è venuta l’ora di farlo, quando la vecchiaia non poteva portare più con se la paura forte di non essere in grado di resistere alla morte, i racconti fossero di una memoria lontana, ma nitida e atroce. C’è chi dice che nel ricordo c’erano quei corpi morti, dilaniati, mezzi bruciati. Corpi da seppellire con poche mani adulte sopravvissute da poter utilizzare e dunque diversi bambini costretti a trasportarli fino al cimitero con i carretti più sgangherati. C’è chi dice che nel ricordo, alla fine di questo orribile trasporto, la mente di questi bambini, feriti dentro, uccisi dal dolore, disfatti, li portasse a ridere lungamente e a singhiozzo. Come se non bastasse il singhiozzo del pianto, come se solo in questo modo la mente di un bambino traducesse il dolore, l’orrenda irrazionalità della barbarie, la sospensione della storia, l’arresto crudele della crescita dell’umanità che il nazismo e il fascismo avevano prodotto.
Dobbiamo sorvolare troppo sulle cose e le parole non bastano.
Ma fermiamoci un attimo, come si fosse a pensarne in silenzio. Pensiamo a quei morti, a quei bambini, ai familiari, alle persone amiche. Pensiamo a come sono stati per i sopravvissuti i giorni seguenti. I mesi successivi. Gli anni a venire. Praticamente in ogni famiglia di questa comunità si è inserito all’improvviso, inaspettato e crudele, l’effetto dirompente di questi eventi. Quanti non avranno saputo come fare a campare? Quanti si saranno detti che non avrebbero più avuto la forza per farlo? A quanti saranno mancati i mezzi.
Eppure questa comunità, come altre, ha resistito. Ne è uscita diversa, stremata, disfatta, ma ha resisitito. Ed ha saputo andare avanti e risorgere avendo chiaro quali siano i valori sui quali puntare.
Come hanno fatto tanti popoli. Cosa li spinse ad andare avanti e a risorgere se non la Liberazione, e con essa la liberazione dai campi di sterminio?! L’umanità riacquisì la sua storia e si aprì ad una nuova era, liberando alla conoscenza di tutti l’orrore di quel periodo e facendo divenire quello spaventoso segreto tra assassini e vittime, un macigno inesorabilmente pesante nella coscienza del genere umano.
Da allora ricordare quel momento storico ha significato e significa farsi carico di cercare di sapere, di capire, di assumere su ognuno di noi il peso di quel dolore, di quelle colpe di altri. Per l’umanità si segnò una data, una fra le poche significative, che marcò la storia del mondo, che rappresentò l’apoteosi del male assoluto che uccide non solo gli uomini, i popoli e le etnie, i deboli ed i diversi, gli avversari politici, ma uccide la verità, cioè l’uomo stesso, che con quei fatti, con quegli orrori, in quegli anni, può dirsi inesorabilmente fallito.
Bene ha fatto questa comunità, le sue istituzioni, a cercare di vederci chiaro in quei fatti. A farci i conti fino in fondo. Ho letto un libro che li ricorda, il prezioso contributo dato da Emilio Polverini, dal soldato inglese Maurice Nash che è divenuto successivamente un prezioso collaboratore nella ricostruzione storica.
Non sta a me entrare nel merito di questa ricostruzione storica. Non è mai chiaro perché un esercito in ritirata compia stragi. Eppure la storia ne è piena.
Certo appare convincente che queste truppe specializzate fossero tra i migliori interpreti di una radice costitutiva del combattente tedesco come voluto da Hitler: strategia del terrore, politica del massacro, pervicace violenza. E che esse fossero ancor più assetate di sangue e intrise di odio nel momento della consapevolezza della ritirata dal territorio di un popolo dal quale si sentivano nuovamente traditi e dunque da disprezzare e da spazzare via.
Certo appare convincente che la particolare collocazione strategica di questo territorio per il ritiro dell’esercito tedesco sulla dorsale appenninica e la necessità di farne terra bruciata per tentare di liberarlo dalle azioni dei partigiani.
Così come appare convincente si volesse colpire laddove la cultura antifascista era più forte e i personaggi legati alla resistenza erano in numero maggiore.
E che i repubblichini locali fossero ben lieti di aiutare i tedeschi contro una terra di comunisti contro i quali vendicarsi.
Bene questa comunità ha fatto e fa a ricordare. Oggi questi fatti hanno il diritto di indicarci chiaramente quale strada non deve essere percorsa, quali conseguenze possono avere anche nel presente e nel futuro scelte di dominio, di sopraffazione, di violenza e di guerra.
Ed abbiamo il dovere di riconoscere il grande valore che ebbe la resistenza, dove, partendo dall’opposizione al fascismo, si compose quello straordinario moto di massa che sfociò, specialmente nella nostra Regione, anno dopo anno, mese dopo mese, nelle molte anime della Resistenza.
E’ un panorama fatto di tante storie e vicende, anche piccole e apparentemente modeste, ognuna delle quali ci concede episodi fondamentali che, visti oggi, riportano alla luce nomi e cognomi, racconti, spesso immagini di uomini e donne con un grande ideale, una voglia di agire e caricarsi della responsabilità della storia inesauribile. Un approccio a tutto ciò fatto di grande semplicità.
Mi ha sempre colpito, io che vengo da una città che La Pira definì la capitale morale della resistenza toscana, conoscere quegli uomini e quelle donne. Persone semplici, che non facevano la retorica della resistenza o dell’antifascismo: raccontavano la loro esperienza non come insieme di atti eroici, ma nella loro naturalezza. Nel riaffermare la necessità di agire, di dare il loro contributo anche alla lotta armata, erano consapevoli di vivere un’esperienza umanamente difficile e lacerante: la morte dei compagni, ma anche degli avversari, le vicende che si snodavano secondo modalità non sempre coerenti: le direttive degli alleati, la disomogeneità dei compagni partigiani, l’imprevedibilità degli eventi.
Come scrisse Carlo Cassola: “Eravamo venuti alla macchia prima di tutto per difendere le ragioni della vita di fronte a che le negava, per innalzare le nostre gioiose bandiere davanti ai gagliardetti col teschio. Se un fascista spagnolo aveva gridato viva la morte! Noi avremmo potuto gridare viva la vita!. Il fascismo era la morte: non per niente spronava alla guerra. Noi, invece, della morte cioè della guerra – non ne volevamo sapere. Politica e vita erano per noi la stessa cosa da partigiani”.
Noi dobbiamo ricordare non un fatto passato e concluso, non il vincitore di fronte al vinto, bensì chi salvò l’Italia di fronte a chi l’aveva portata alla rovina, da quella rovina da cui poteva nascere un secondo risorgimento, un “impulso alla rigenerazione totale” (così scriveva Giaime Pintor nell’ottobre 1943, pochi giorni prima di morire cercando di raggiungere le prime formazioni partigiane).
Sulla eticità dei valori della Costituzione nata dalla Resistenza credo sia doveroso insistere proprio per il suo sessantesimo anno di vita. Utilizzare ogni occasione por difendere la nostra Carta Costituzionale sapendo che è stato con essa che hanno preso il cammino la democrazia italiana, le conquiste civili, sociali, economiche del nostro paese, la conquista della libertà e della democrazia. Onore, dignità, speranza, pace, giustizia, libertà non sono parole qualsiasi, ma racchiudono i valori della Resistenza, di chi si impegnò nella lotta attiva, di chi prese le armi, ma anche della gente che silenziosamente aiutò i partigiani, soccorse i feriti, nascose gli ebrei esponendosi a rischi enormi e ancora dei prigionieri italiani nei campi di concentramento che si rifiutarono di collaborare con i nazisti e con i fascisti della Repubblica Sociale Italiana. Tutti valori che si contrapposero all’odio, al razzismo, alla sopraffazione, al totalitarismo, alla barbarie, allo sterminio, alla negazione della dignità umana.
Spesso si parla, in specie da parte di alcune forze politiche, di “riconciliazione nazionale” e si afferma che tutti i morti di tutte le parti in lotta sono degni di rispetto e pietà. Credo che nessuno possa dichiararsi contrario. Ma deve essere chiaro che dietro questa formula non può nascondersi una pericolosa equazione secondo cui nessuno aveva ragione e nessuno aveva torto, da qualunque parte avesse scelto di stare.
Nel 1945 di fronte all’Europa distrutta il grande scrittore tedesco Thomas Mann vedeva “dall’estrema disperazione” sorgere una nuova speranza: era la speranza del superamento degli egoismi nazionali, dell’affermarsi della pace e della sicurezza. Oggi il consenso dei cittadini per l’unità dell’Europa e per le sue istituzioni si deve fondare non sull’oblio ma sulla consapevolezza del passato, proprio per riaffermare i valori fondamentali della nostra civiltà.
Il sentimento di pace, l’importanza della solidarietà tra i popoli non poteva che essere fortissimo alla fine della guerra più catastrofica nella storia dell’umanità. Ma si continua con le guerre.
Dobbiamo insistere sulla eticità dei valori della Resistenza e della Costituzione, quell’eticità che si ritrova in anche nel grande lavoro di ricostruzione storica e di ammissione delle responsabilità che il popolo tedesco ha iniziato sei anni fa con la visita che il Presidente della Repubblica Federale di Germania compì a Marzabotto, città simbolo delle stragi nazifasciste in Italia, affermando, rivolto ai superstiti e ai familiari delle vittime: “Voi avete conservato e tenuto vivo il ricordo delle vittime del massacro. Non l’avete fatto per mantenere vivo l’odio o per vendicarvi. L’avete fatto per amore del futuro, per amore del nostro futuro comune”. Sono parole importanti. Alle quali sono seguiti tanti fatti positivi che ora si sono tradotti in lezioni importantissime che si tengono nelle scuole tedesche.
In quelle lezioni c’è tanto. Ci sono purtroppo anche i 191 civili che siamo oggi a celebrare.
Un’umanità diversa avrebbe potuto arrivarci anche senza questa e molte altre orrende stragi, ad iniziare da quelle nei lager nazisti. Ma certamente non è stata colpa delle vittime se la storia si è scritta così. E’ semmai in loro onore se essa ha saputo risollevarsi e tornare libera. Adesso, per tenere alto l’onore delle vittime, oltre a ricordarle, occorre lavorare perchè gli ideali dei giovani sappiano costruirsi in modo tale da non ripetere quegli errori. Tocca a noi tutti, tutti i giorni. In forme nuove, più accattivanti per i nostri ragazzi, ma occorre farlo.
La nostra specie non acquisisce nel proprio patrimonio genetico quanto a livello culturale il genere umano e i singoli popoli hanno maturato: ogni nuova generazione la deve ricostruire e le generazioni che l’hanno preceduta devono trasmetterla.
Grazie